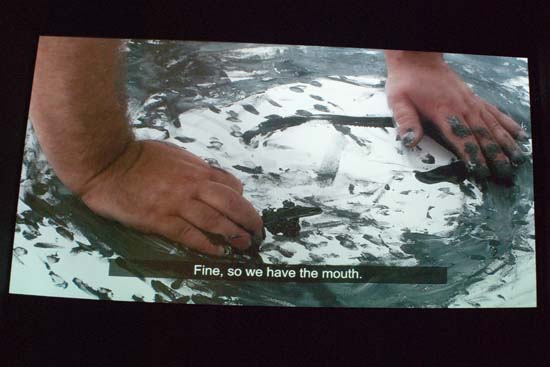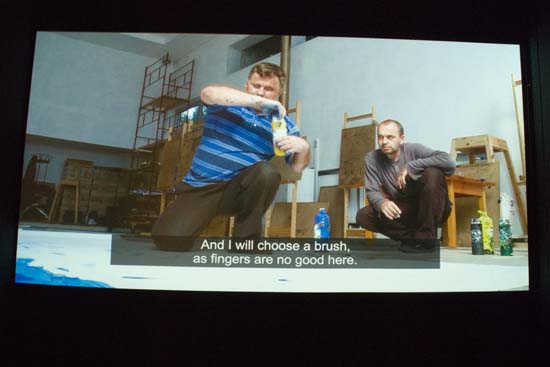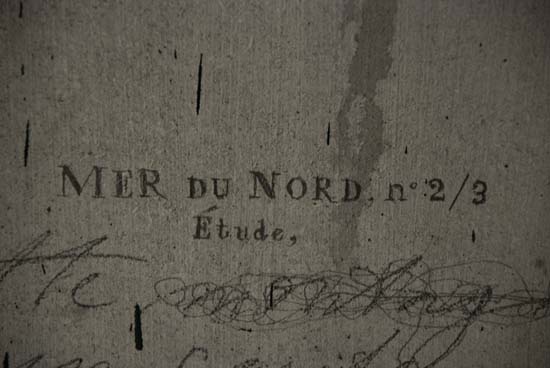«Solenne come figlia di re sotto quel padiglione soppannato di ermellini, essa è tuttavia rustica come una giovane montanina che venga sulla porta della carbonaia»
(da Roberto Longhi, Piero della Francesca, Abscondita, p.84)
«Quando sono tornato a Monterchi ho scoperto che l’affresco era stato staccato dal muro della cappella posta all’ingresso del vecchio cimitero e rimontato su un muro della scuola del paese. La costruzione sfoggia un’architettura di stile fascista degli anni 1932-1933 e la Madonna di Piero è stata messa sotto vetro, incorniciata e illuminata in modo tale da sembrare ormai una diapositiva proiettata sullo schermo. Non è più possibile distinguere la natura di pittura a fresco, e neanche capire se si tratta dell’opera originale o di una riproduzione. Quanto ai vasti spazi ormai dismessi, sale e aule, sono stati trasformati in “shops”, come sta scritto, negozi di souvenir e “prodotti derivati”. Le masse dei turisti che si riversano dai pullman ogni estate hanno sostituito le processioni delle fanciulle vicine a partorire»
(da Jean Clair, L’inverno della cultura, Skira, p.87)
C’è un che di ipnotico in quel «viso da mustela» (Longhi), in quell’irreale apertura simmetricissima della tenda. C’è una quantità di pensiero che atterrisce chi ha la tendenza a guardare opere d’arte più con la pancia che con la testa. Uscendo dalla vecchia scuola elementare di Monterchi è quasi obbligatorio domandarsi se aveva ragione Berenson quando scriveva: «Oso dunque affermare che nei suoi momenti quasi universalmente reputati supremi, l’arte è sempre stata ineloquente come in Piero della Francesca, sempre, come in lui, muta e gloriosa».
***
Come scrive Jean Clair, l’allestimento della Madonna del parto è la quintessenza della musealizzazione. Qui mai come altrove si sente la violenza dello “strappo” dell’affresco. La teca climatizzata è pulita e ortogonale, opera di un Donald Judd della Valtiberina, e sembra fare eco alle splendide geometrie di Pietro. Eppure, allo stesso modo miracoloso in cui dentro il rigoroso padiglione di ermellini appare quasi ruspante la bellezza della “giovane montanina”, anche nella scuola di Monterchi va in scena qualcosa di assolutamente sorprendente. Lì, nella penombra della saletta, appoggiati con grazia si trovano una serie di mazzi di fiori omaggio devoto delle giovani donne incinte dei paesi vicini. Neanche la musealizzazione più selvaggia è riuscita a disinnescare l’affezione popolare a questa immagine senza tempo.
Nella foto qui sotto si intravvedono i fiori.